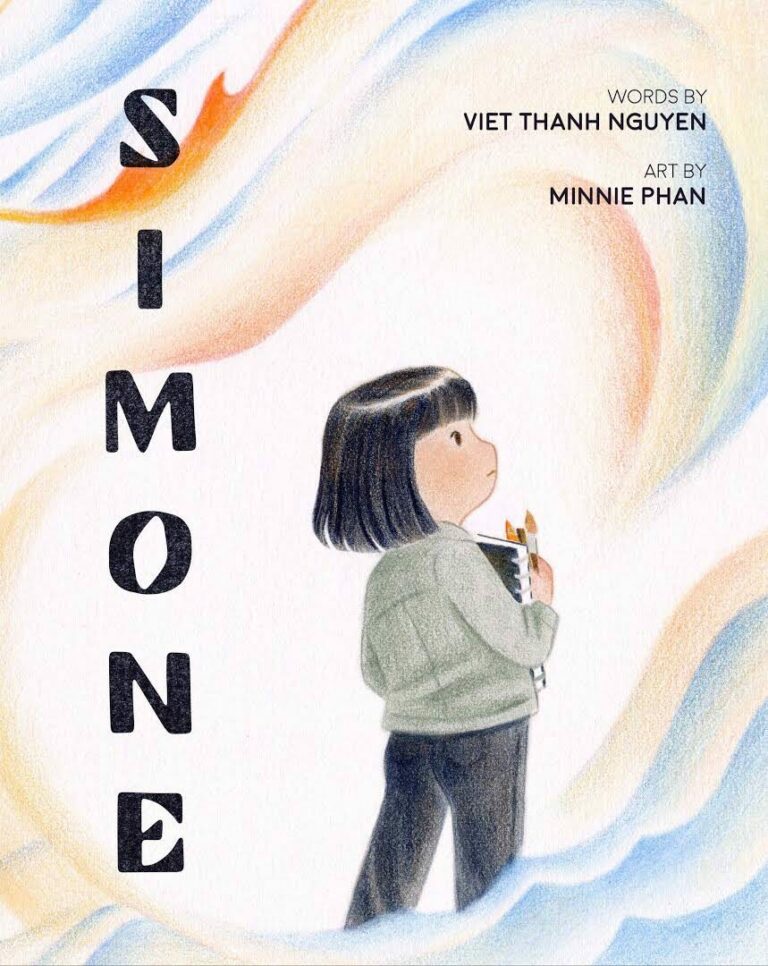Melania Mazzucco writes a review of the short stories within Viet Thanh Nguyen’s The Refugees for Italy’s la Repubblica.

I personaggi di Viet Thanh Nguyen, premio Pulitzer per “Il simpatizzante”, vivono sospesi tra la necessità di dimenticare e quella di ricordare la storia da cui provengono. Sono “I rifugiati” del titolo del nuovo libro dell’autore vietnamita: otto racconti di uomini in bilico in cerca di futuro
Nell’ultima pagina de Il simpatizzante, il pirotecnico romanzo con cui Viet Thanh Nguyen ha vinto il premio Pulitzer nel 2016, l’anonimo narratore, spia comunista infiltrata nei servizi di sicurezza sudvietnamiti finanziati dalla Cia, dopo essere sopravvissuto alle torture del campo di rieducazione si accinge a lasciare il Vietnam su un’imbarcazione di fortuna e a diventare, confuso nella massa di uomini, donne e bambini (non di vecchi, perché non sopravviverebbero al viaggio), uno qualunque dei cosiddetti “boat people”.
«Un nome che ci infastidisce un po’», commenta: «puzza di condiscendenza da antropologi; sembra evocare una branca dimenticata della famiglia umana, una tribù perduta di anfibi che emerga dalle nebbie dell’oceano». Insomma, il protagonista diventa un rifugiato.
Non stupisce perciò che il secondo libro di Nguyen (in uscita per Neri Pozza), a sua volta rifugiato (arrivato dal Vietnam negli Usa nel 1975, a quattro anni), figlio di rifugiati e marito di una rifugiata, si intitoli proprio I rifugiati e narri le storie di quei “boat people” o dei loro figli, anche molti anni dopo il loro trapianto negli Stati Uniti.
Gli otto racconti sono ambientati nella comunità vietnamita-americana, ma la dedica della raccolta “ai rifugiati sparsi nel mondo” invita a leggerli come storie universali. E contemporanee: oggi nel mondo vi sono più di sessanta milioni di rifugiati.
Chi ha già letto Il simpatizzante vi riconoscerà il leit-motiv dell’identità duplice (lì tematizzata nella doppiezza della spia protagonista), ma declinato in forme, toni e stile affatto nuovi. Quanto il romanzo era sperimentale e virtuosistico, tanto le novelle sono dimesse e scarne. Non ci sono spie, criminali, torturatori. Ma persone comuni, ragazzini, professori, bibliotecari, negozianti di generi alimentari, che cercano con fatica di rifarsi una vita nella nuova patria, disorientati dalla perdita del proprio Paese, lingua, identità, ma anche da costumi e abitudini di una cultura aliena. Nel racconto Un altro uomo, il diciottenne Liem viene accolto da un professore gay di San Francisco che convive col suo ragazzo di Hong Kong: la legislazione statunitense prevede che il rifugiato possa uscire dal campo profughi solo se un cittadino americano gli fa da sponsor — lo scontro-incontro di mondi e culture è privo di filtro, immediato, talvolta scioccante. Ma anche una volta integrati o assimilati, come direbbe il gergo sociologico, i rifugiati hanno sempre l’impressione di non essere al proprio posto. I figli si vergognano dei padri o delle madri troppo vietnamiti, i padri e le madri trovano troppo americani i loro figli salvati, e si struggono per i figli rimasti dall’altra parte dell’Oceano, assenti, perduti, svaniti.
Tutti, come annunciato dalle epigrafi (una di Bolaño, l’altra di James Fenton), sono lacerati tra due imperativi morali opposti: dimenticare e ricordare. (E infatti il racconto Se solo mi volessi, intimistico ed elegiaco, ha per protagonista la moglie di un malato di Alzheimer, dalla cui memoria in dissesto riemerge un frammento negato d’amore felice). La guerra e l’orrore sono altrove: il non detto, l’indicibile, l’incubo che perseguita i sopravvissuti e i loro discendenti (ne Gli americani la figlia di una giapponese e di un militare che ha bombardato il Vietnam, e che negli Usa è sempre stata disprezzata per essere di razza mista, si riappacifica con sé stessa e col padre solo diventando “vietnamita nell’anima”). Il passato traumatico può affiorare solo dopo una rottura della quotidianità, e si materializza nell’apparizione dei fantasmi: non metaforici ma reali, che si insediano nella vita dei protagonisti — costringendoli ad affrontare il loro rimosso. Come il fantasma del fratello della protagonista di Donne dagli occhi neri, morto durante la traversata, per salvarla. La donna è a sua volta una ghostwriter: scrive per conto terzi e in sostanza va a caccia di fantasmi, cioè di storie. Così che il racconto è anche una riflessione sulla scrittura: “Le storie sono cose che fabbrichiamo: nient’altro. Le cerchiamo in un mondo che non è il nostro e poi le lasciamo perché qualcuno le trovi, come altrettanti indumenti abbandonati dai fantasmi”. Ma il racconto più riuscito è forse l’ultimo, La terra del padre, ambientato nella Saigon del 2001 (dopo la visita di Clinton che voleva sancire la riconciliazione degli Usa col loro passato). Ha al suo centro il tema del doppio, capitale nella narrativa di Ngyuen (e anche della sua saggistica, essendo autore di Race and Resistance. Literature and politics in Asian America). È la storia di due sorellastre, una cresciuta in Vietnam, l’altra in America. Il padre ha dato ai tre figli del secondo matrimonio i nomi di quelli del primo: perché la vita va avanti, ma la prima vita è esistita e non sarà mai cancellata. Molti anni dopo, la Phuong americana (che ora si fa chiamare Vivien) viene a conoscere il padre a Saigon, e la sorella omonima. Ma nessuno è ciò che sembra, tutti mentono e hanno mentito: la nuova identità dei rifugiati si costruisce spesso sulla menzogna, e quella che accomoda chi resta non è meno bugiarda: le due vite, le due famiglie non possono più ricomporsi. Nell’ultima scena, Phuong brucia la foto che la raffigura con la “gemella” americana. Quasi Ngyuen volesse suggerire che la riconciliazione di un’anima per sempre divisa, delle sue culture, delle sue identità, è possibile solo nella libertà inesauribile della scrittura.